ANALISI METALLOGRAFICA
L'analisi metallografica consiste nell'esame dei materiali metallici con il microscopio metallografico. A questa operazione deve essere preceduta una fase di preparazione dei provini. Questi ultimi infatti, prima di poter essere analizzati allo spettrometro, devono subire un processo definito lappatura: si tratta di una accurata levigatura eseguita con opportuni dischi abrasivi applicati ad una smerigliatrice. Tali dischi vengono imbevuti di una miscela di acqua e polvere diamantata: in questo modo viene a formarsi una superficie perfettamente liscia che consente una lucidatura a specchio del saggio di materiale in esame.
Alla lappatura deve seguire un attacco chimico della superficie da esaminare con opportuni reattivi (variabili a seconda della natura del saggio in questione) che mettono in evidenza la struttura del materiale. Infatti alcuni costituenti non vengono attaccati e rimangono brillanti; altri, in seguito alla reazione diventano scuri e colorati.
Ora si passa all'ingrandimento microscopico vero e proprio la cui sequenza risulta essere la seguente:
• X 200, per il rilevamento di eventuali fenomeni di corrosione;
• X 500, necessario per individuare strutture di trattamento termico.
• Oltre X 750, per mettere in evidenza strutture più fini.
In tutti i casi viene evidenziata la struttura delle leghe ferrose (percentuali di perlite, ferrite). Tramite la consultazione dei cataloghi infine si confrontano le proiezioni su monitor delle zone analizzate con le immagini riportate sui manuali potendo così classificare il materiale. Sui cataloghi sono inoltre ricondotte le possibili lavorazioni subite dall'oggetto stesso o gli impieghi a cui esso è destinato.
PROVA DI DUREZZA
La prova di durezza può essere eseguita con tre metodi, a seconda del materiale su cui è svolta:
Brinell
La prova consiste nel premere una sfera levigata in acciaio temperato, per un tempo prestabilito, con una prefissata forza F contro l superficie della provetta in esame, e nel misurare il diametro medio d dell'impronta rimasta sulla superficie dopo la rimozione della forza F.
DUREZZA BRINELL = F/S
Vickers
La prova si esegue premendo il penetratore contro la superficie del pezzo (o della provetta) in prova, sotto l'azione di una forza F (carico di prova) e rilevando (dopo la rimozione della suddetta forza), la lunghezza della diagonale media d, ottenuta facendo, appunto, la media aritmetica tra le due diagonali d 1 e d 2 dell'impronta lasciata sulla superficie dal penetratore di diamante a forma di piramide retta a base quadrata con angolo fra le facce opposte al vertice di 136° ± 0,5°.
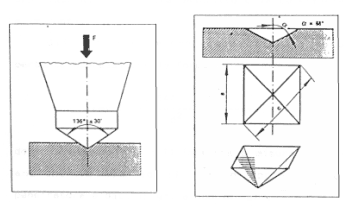
DUREZZA VICKERS = F/S
Rockwell
Consiste nel far penetrare, in due tempi, sulla superficie del pezzo (o della provetta) in prova, un penetratore di tipo unificato e nel misuratore, l'accrescimento rimanente e della profondità dell'impronta di detto penetratore. La durezza Rockwell è pertanto misurata in funzione dell'accrescimento rimanente e la cui unità è uguale a 0,002 mm.
Per questo tipo di prova sono utilizzati due tipi di penetratori:
A cono e a sfera
DUREZZA ROCKWELL = F/S
GALDABINI PM 60
La macchina Galdabini PM 60 è di tipo universale, essa può essere quindi utilizzata per prove di compressione, flessione, taglio e durezza.
Una macchina è composta da un basamento che sostiene gli organi di sollecitazione, il monitor per la misurazione degli sforzi e la stampante per la visualizzazione dei diagrammi.
Gli organi di sollecitazione sono costituiti da due colonne che portano una traversa su cui è sistemato il cilindro principale entro il quale scorre il pistone che esercita lo sforzo. Il pistone è sormontato da una traversina la quale regge per mezzo di due tiranti una mensola, su questa si appoggiano i provini.
IL funzionamento della macchina è idraulico, lo stantuffo viene mosso dalla pressione dell'olio ed esercita lo sforzo sulla provetta per mezzo dei tiranti cui è collegato. Lo sforzo massimo che può sviluppare questa macchina è di 60 KN.
Per l'elaborazione dei dagli sforzi la macchina è munita di un trasduttore elettronico che permette l'elaborazione dei diagrammi sforzo/allungamento. Per l'esecuzione delle diverse prove è semplicemente necessario sostituire le teste della prova di trazione con gli accessori appositi (coltelli, appoggi) applicati alla mensola e alla traversa mobile.
LIQUIDI PENETRANTI
Quando si vogliono ricercare difetti affioranti alla superficie del materiale si può effettuare l'esame con i liquidi penetranti, che presenta il vantaggio di essere estremamente semplice e di non richiedere attrezzature speciali. La superficie del pezzo in esame viene trattata, per verniciatura o per immersione, con un liquido a bassa tensione superficiale che penetra in tutte le discontinuità della superficie e, in particolare in qualche eventuale incrinatura o fessurazione. Dopo l'impregnazione, il liquido in eccesso viene accuratamente asportato dalla superficie, su cui si cosparge una polvere finissima che assorbe il liquido residuo trattenuto da eventuali fessurazioni superficiali. Il liquido viene così riportato in superficie e messo in evidenza per contrasto di colore. Si possono ottenere ottimi risultati facendo uso di una polvere bianca che risulta essere ben visibile con l'ausilio della luce di Wood.
PROIETTORE DI PROFILI
Un'altra apparecchiatura di indiscussa utilità è il proiettore diascopico impiegato comunemente per il controllo relativo ai profili: esso ingrandisce di 10, 20 o 50 volte il pezzo in esame la cui proiezione su uno schermo traslucido viene confrontata con la rappresentazione su carta del profilo ideale accompagnata dalle tolleranze ammesse.
Nelle officine la rappresentazione dei profili e delle relative tolleranze viene eseguita su lastre di vetro in modo tale che siano sempre disponibili.
PROVA JOMINY
Durante il corso di studi, una delle prove di temprabilità effettuate dagli allievi è la cosiddetta Jominy ( o della tempra di estremità). Essa consiste nel raffreddare con un getto d'acqua a 24°C, l'estremo di una barretta del diametro di 25 mm, la quale sia stata riscaldata alla temperatura di tempra. Un apposito impianto fa in modo che il getto possa colpire, dal basso verso l'alto, solo l'estremità della barretta, mantenuta in posizione verticale da un sostegno.
Il controllo del getto d'acqua si effettua misurando il diametro dell'ombrello d'acqua che si viene a creare quando il getto urta contro la provetta. A raffreddamento avvenuto si praticano con una rettificatrice due superfici parallele all'asse della barretta, in modo che il massimo spessore di materiale asportato sia di 0,38 mm; successivamente si eseguono lungo queste due superfici una serie di prove di durezza Rockwell con impronte distanti fra loro 1,5 mm. I valori di durezza misurati si riportano poi in un diagramma , indicando in ascissa le distanze progressive dall'estremità della provetta ed in ordinata le durezze corrispondenti: si ottengono così le curve di temprabilità per tempra ad un estremo, o curve Jominy.
PROVA DI RESILIENZA
Nel laboratorio tecnologico è possibile attuare la prova di resilienza che consiste nel verificare la resistenza che un materiale oppone ad un urto. Tale prova può essere eseguita attraverso l'utilizzo del maglio a pendolo di Charpy. Quest'ultimo è formato dalle seguenti parti:
• Incastellatura con basamento
• Pendolo ad asta con mazza
• Appoggi per la provetta
• Dispositivo misuratore della resilienza
• Un freno per l'arresto del pendolo (eventuale)
• Un sistema meccanico per l'innalzamento dell'asta (eventuale)
• Una struttura in plexiglass di protezione
Si tratta di una prova distruttiva, che si esegue su dei piccoli provini del materiale in esame, che sono spezzati dalla forza d'urto del maglio. I provini presentano degli intagli atti a facilitare la rottura per urto in quello specifico punto. Vi sono principalmente due tipi d'intaglio:
• A forma di U per materiali non ferrosi
• A forma di V per materiali ferrosi
Per eseguire la prova sono necessari almeno tre provini per ogni materiale campione, e la supervisione dell'aiutante tecnico del laboratorio.
Prima di cominciare è necessario seguire delle operazioni preliminari come la taratura della macchina, la misura delle dimensioni delle provette metalliche (forma, tipo d'intaglio) la preparazione del PC (connesso al pendolo). Il computer ci permette, attraverso il programma PSW, di rilevare i dati della macchina di prova (la comunicazione avviene attraverso un cavo d'ingresso dati).
La prova di resilienza può essere eseguita con provini portati a temperatura inferiore a quella ambiente (prova a freddo). Le temperature da raggiungere sono spesso molto basse (anche inferiori a -50°C), perciò ci si avvale di un altro strumento che troviamo in laboratorio tecnologico: la macchina frigorifera . Quest'ultima funziona a liquido e prima di essere usata deve avere raggiunto la temperatura di prova da almeno 15 minuti.
Una volta compiuti tutti i preliminari si procede alla rottura dei provini, secondo la norma UNI EN vigente, ponendoli sugli appoggi e controllando ogni tre campioni il corretto posizionamento della dima di appoggio.
PROVA DI TRAZIONE E/O COMPRESSIONE
Il laboratorio tecnologico dispone di tre macchine per l'esecuzione di prove di trazione /compressione.
Le due macchine più grandi del laboratorio sono di tipo universale e sono la Amsler da 100 KN e la Galdabini PM 60; esse sono in grado di eseguire in sostanza tutte le prove meccaniche di statica, mediante una semplice preparazione.
Il terzo strumento è più piccolo e serve per determinare la resistenza a trazione di fili di ferro o provette di ridotte dimensioni.
La prova di trazione indubbiamente è la prova meccanica più importante, essa consiste nel sottoporre una provetta a uno sforzo gradualmente crescente di trazione fino al pervenire della rottura del pezzo.
Per fare questo, si blocca la provetta tra le due teste dello strumento e successivamente per mezzo di una manopola si applica il carico gradualmente, le teste iniziano ad applicare il carico di trazione fino alla completa rottura, a questo punto si potranno leggere i risultati della prova sullo schermo del computer collegato alla macchina e successivamente stamparli. Con la prova di trazione si perviene a indici che riguardano l'elasticità, la deformabilità e la resistenza dei materiali.
Le provette utilizzate per la prova possono assumere dimensioni e forme diverse a seconda del costruttore e del tipo di prova da effettuare. Le più utilizzate sono quelle a sezione tonda, piatta a tubo o a tegola. Possono essere effettuate inoltre prove di trazione su tondini di acciaio impiegati in edilizia.
Per l'esecuzione della prova ci si riferisce come sempre alle norme UNI reperibili in biblioteca, esse contengono tutte le istruzioni per la preparazione del provino e della macchina e per l'esecuzione degli eventuali calcoli.