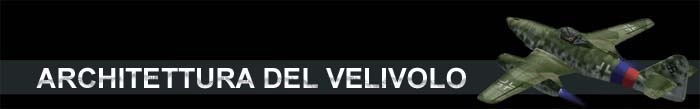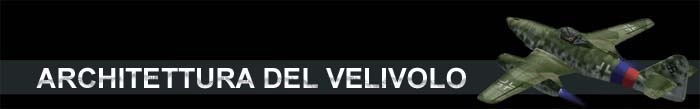LA STRUTTURA
ALARE:

 Il
Messerschmitt Me. 262 A-1a era un aviogetto ad ala bassa, con i due reattori
installati in gondole il cui dorso si raccordava con quello dell’ala,
impennaggi cruciformi e carrello triciclo anteriore retrattile.
Il
Messerschmitt Me. 262 A-1a era un aviogetto ad ala bassa, con i due reattori
installati in gondole il cui dorso si raccordava con quello dell’ala,
impennaggi cruciformi e carrello triciclo anteriore retrattile.
 L’ala,
con un diedro frontale di 6 gradi e una freccia sul bordo di attacco di 18°32’,
era costituita da due semiali, ciascuna su un robusto longherone a doppio T con
solette in acciaio ed anima in lega leggera, un longheroncino posteriore,
ventuno centine e diversi correntizi di irrigidimento. Le due semiali, collegate
tra loro da piastre bullonate, erano vincolate alla fusoliera mediante quattro
spinotti e due profilati ad L. L’intero bordo di attacco alare era occupato da
un’alula HP automatica in lamiera di acciaio, in tre elementi per semiala, e
quello di uscita dagli ipersostentatori a scorrimento in quattro elementi (con
angolazione massima di 60°) e dagli alettoni Frise (muniti di alette
compensatrici), entrambi completamente metallici.
L’ala,
con un diedro frontale di 6 gradi e una freccia sul bordo di attacco di 18°32’,
era costituita da due semiali, ciascuna su un robusto longherone a doppio T con
solette in acciaio ed anima in lega leggera, un longheroncino posteriore,
ventuno centine e diversi correntizi di irrigidimento. Le due semiali, collegate
tra loro da piastre bullonate, erano vincolate alla fusoliera mediante quattro
spinotti e due profilati ad L. L’intero bordo di attacco alare era occupato da
un’alula HP automatica in lamiera di acciaio, in tre elementi per semiala, e
quello di uscita dagli ipersostentatori a scorrimento in quattro elementi (con
angolazione massima di 60°) e dagli alettoni Frise (muniti di alette
compensatrici), entrambi completamente metallici.
ALETTONE
FRISE:
L’alettone che si
abbassa, provoca un aumento locale del Cp del profilo, quello che si alza ne
genera una diminuzione. Tale incremento, influenzando la resistenza indotta, fa
nascere una assimetria tra le resistenze aerodinamiche delle due semiali, che dà
luogo ad un momento imbardante, che tende a far ruotare il velivolo intorno
all’asse Z, in modo tale che la semiala più portante indietreggi. In volo il
pilota corregge questa rotazione agendo sul timone direzionale. Poiché uno
degli obbiettivi principali della progettazione consiste nella riduzione delle
manovre correttive richieste al pilota, venne introdotto l’alettone Frise, nel
quale la manovra di virata fa sporgere brutalmente dal profilo alare il bordo di
attacco dell’alettone deportante, in modo che si comporti come un vero e
proprio freno aerodinamico compensando il momento imbardante
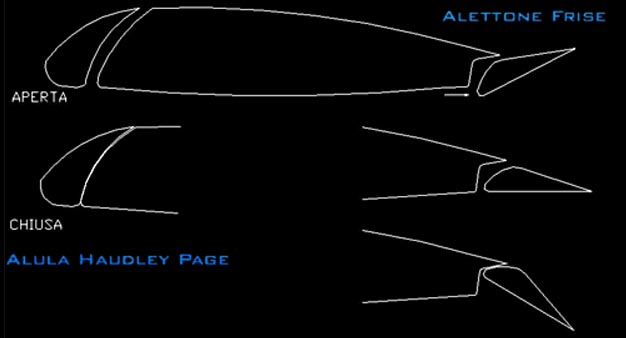
L’ALULA HAUDLEY
PAGE:
Gli
ipersostentatori si distinguono in due categorie: quelli che agiscono sul bordo
di attacco e quelli che agiscono sul bordo di fuga.
I
primi spostano il distacco della vena ad incidenze più elevate; gli altri
accentuano la curvatura del profilo, aumentando la superficie ed incrementando
quindi la portanza a parità di incidenza geometrica.
Tipico
ipersostentatore del bordo di attacco è l’alula Hadley Page. A parità di
incidenza, con questa aletta è possibile ottenere un Cpmax ad un’incidenza
molto più elevata che non con gli altri tipi di ipersostentatori.
LA FUSOLIERA:
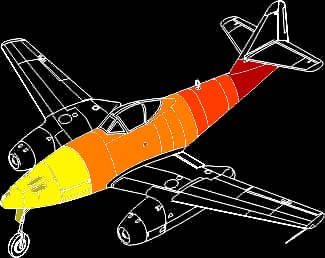
La
fusoliera, a struttura a semiguscio, era a sezione pressoché triangolare, ed
era costituita da quattro elementi principali:
Il muso:
 Venne costruito prevalentemente in lamiera di
acciaio, al fine di sopportare i carichi
prodotti dalla gamba anteriore del carrello e dal pesante armamento (quattro
cannoncini MK109 da 30 millimetri, i due inferiori con 85 proiettili, i due superiori
con 100).
Venne costruito prevalentemente in lamiera di
acciaio, al fine di sopportare i carichi
prodotti dalla gamba anteriore del carrello e dal pesante armamento (quattro
cannoncini MK109 da 30 millimetri, i due inferiori con 85 proiettili, i due superiori
con 100).

Il tronco centrale:
La
zona centrale della fusoliera comprendeva il cockpit (abitacolo) dotato di
blindatura di spessore mm 20 con la copertura in plexiglas blindato (da 90mm)
incernierata sul lato destro. La parte anteriore della cabina di spessore mm 50
era riscaldata elettricamente con fili molto sottili, mentre posteriormente vi
era una blindatura completa.

Il tronco posteriore:
Vi
era collocata la radio FuG 16Z o ZY abbinata ad un trasponder Fug 25a.
Il cono posteriore:
Venne
progettato e costruito in maniera solidale con la deriva ed ottenuto interamente
in dural con fasciame conico di rinforzo.
I PIANI DI CODA:
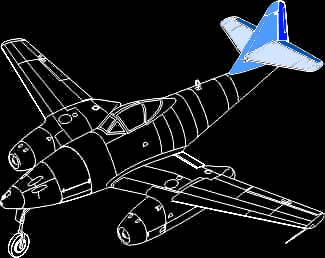
Gli
impennaggi, di ridotto allungamento e marcatamente rastremati, erano costituiti
da uno stabilizzatore a calettamento variabile elettricamente, dalla deriva, dai
due semiequilibratori e dal timone, tutti metallici ad eccezione del bordo
d’attacco della deriva in legno. Le superfici mobili, tutte contrappesate,
erano munite di alette correttrici.
I CARRELLI:
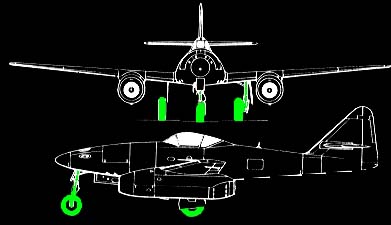
 Le
gambe del carrello, munite di ammortizzatori oleopneumatici, avevano ruote da 84
(le posteriori) e da 66 centimetri di diametro (l’anteriore). Il carrello, la
cui gamba anteriore rientrava all’indietro nel muso, e le posteriori di piatto
nell’ala, ruotando verso l’asse del velivolo e con le ruote che si
occultavano nel ventre della fusoliera, era la parte meno soddisfacente
dell’aereo, ed in particolare i cedimenti della gamba anteriore e gli scoppi
del suo pneumatico furono una delle più frequenti cause di incidenti.
Le
gambe del carrello, munite di ammortizzatori oleopneumatici, avevano ruote da 84
(le posteriori) e da 66 centimetri di diametro (l’anteriore). Il carrello, la
cui gamba anteriore rientrava all’indietro nel muso, e le posteriori di piatto
nell’ala, ruotando verso l’asse del velivolo e con le ruote che si
occultavano nel ventre della fusoliera, era la parte meno soddisfacente
dell’aereo, ed in particolare i cedimenti della gamba anteriore e gli scoppi
del suo pneumatico furono una delle più frequenti cause di incidenti.